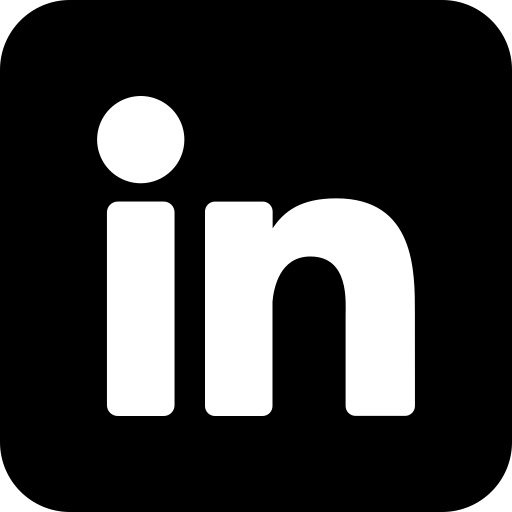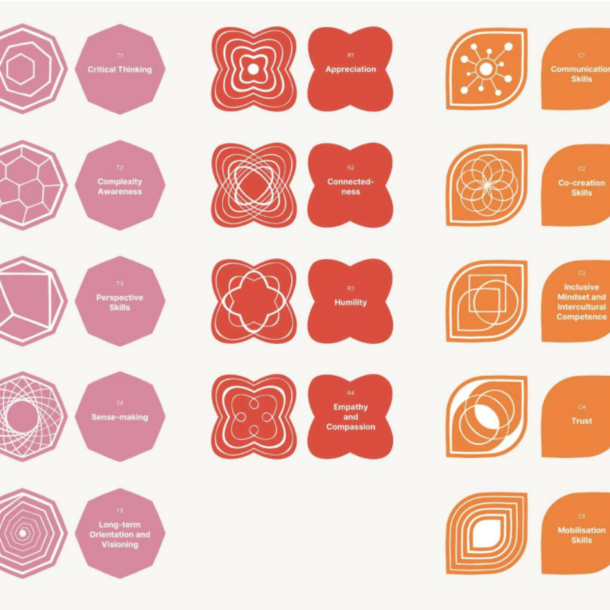
Ricerca organizzativa: il dietro le quinte di un’indagine volta a esplorare dinamiche sommerse nella sanità e di una progettazione collaborativa.

La relazione con il cliente può essere vista come uno spazio di comprensione e osservazione culturale, in cui si studiano le dinamiche, i comportamenti e le interazioni tra l’azienda e i suoi clienti, simile a un contesto etnografico in cui si esplorano diverse sfumature e significati di queste interazioni.
Alcuni anni fa, un ente pubblico del Servizio Sanitario Nazionale operante in provincia di Trento mostrava l’esigenza specifica di capire e affrontare il perché la performance di lavoro tra stakeholder appartenenti a diverse categorie professionali (medici di medicina generale, anche MMG, infermieri domiciliari, assistenti sociali, etc) non fosse così alta come ci si aspettava. Inoltre c’era l’esigenza di capire la relazione tra questi attori con le tecnologie allora in uso. Le informazioni alle quali si era giunti furono inquadrate all’interno di un progetto di cambiamento organizzativo e tecnologico che prevedeva l’evoluzione di procedure e artefatti in grado di migliorare e malleare la relazione tra le figure coinvolte e l’intero ecosistema culturale sul quale operavano gli attori stessi.
L’opinione comune dell’organizzazione pubblica era che non esistessero mezzi o procedure valoriali tali da supportare una proficua collaborazione tra attori (il campo d’indagine risale all’anno 2010). Ma quando un’analisi comportamentale comparativa mostrò che altre realtà simili (principalmente all’estero) erano in grado di sostenere rapporti e ambienti di lavoro maggiormente collaborativi anche senza introdurre innovazioni tecnologiche disruptive, fu facile immaginare che le cause del problema non fossero solo di ordine tecnologico ma anche strutturali, o per meglio dire valoriali, e in seno ad ogni categoria di lavoratori coinvolta. L’ente pubblico accettò e decise di procedere con un approfondimento sulla cultura organizzativa per ottenere più spunti sia sul perché sia sul come attenuare e, ove possibile, migliorare la situazione di chi era coinvolto nell’operato quotidiano pubblico.
La domanda Chiave
C’è da dire che di solito le organizzazioni fanno riferimento all’indagine sulla cultura tendenzialmente per studiare trend di determinati settori della società, quindi per comprendere il mondo “esterno all’organizzazione committente”. Tuttavia fondare dei processi di cambiamente su alcuni approfondimenti, e/o dati interni comparati, seppur ricchi di know-how precedentemente nascosto, non significa immediatamente creare valore. Fin dalle mie prime esperienze ho compreso che, affinché gli insight raccolti fossero realmente utili, quindi importanti, l’ambito del mio progetto di indagine e d’azione avrebbe dovuto includere anche la comprensione e supporto all’evoluzione della cultura organizzativa del cliente, allargando le maglie di un processo di miglioramento delle performance del servizio e allo stesso tempo, del benessere organizzativo del network in esame. Quindi combinare sia dati comparativi sia dati raccolti in loco.
Questa riflessione pratica mi ha portato a generare una serie di indagini culturali e domande del tipo: Chi gestisce i rapporti tra le varie categorie professionali? Quali sono i vincoli per legge, e quali invece sono i principi operativi in mano ad ciascun professionista? (Per fare un esempio reale oggi si potrebbe pensare ad una relazione similare in termini di processi di raggiungimento del risultato in un network di attori che vede insieme medici a gettone, pazienti in ospedale e a casa, infermieri ospedalieri e territoriali, operatori altri delle burocrazia pubblica e via dicendo). Quale dovrebbe essere il reale motivo di questa collaborazione che sembra andare a intermittenza? Cosa impedisce agli attori (pubblici e privati) di percepire un senso di appartenenza alla loro missione quotidiana? Ho deciso quindi di affrontare il progetto con un approccio di ricerca che comprenda sia indagini culturali di tipo etnografico sul campo sia un’analisi a più ampio spettro del funzionamento del settore sanitario regionale.
Accesso al campo e costruzione della fiducia
Per prima cosa bisogna sottolineare che è stato fondamentale aver cercato e ottenuto, l’accesso al campo, così come aver costruito un rapporto di fiducia con i molteplici stakeholder in tutti gli appuntamente chiave: dal direttore ospedaliero territoriale, al capo reparto, dalla responsabile infermieristica, a chi informalmente, ma di fatto, aveva voce in capitolo, data la presenza storica sul posto di lavoro. Era un segnale incoraggiante: più persone coinvolte significava che sarebbero state condivise più conoscenze, che a loro volta mi avrebbero aiutato a inquadrare la ricerca, e a condividerla in ogni momento chiave; o almeno così pensavo. In parallelo, portavo avanti anche una presenza sia progettuale che operativa tra chi avrebbe poi implementato l’innovazione di progetto, ossia le aziende di consulenza e due dipartimenti universitari di due città distinte. Inoltre era anche sorprendente vivere diversi climi organizzativi. In particolare si percepivano le dinamiche collaborative che si costruivano tra i gruppi cross-funzionali con i quali mi interfacciavo: da una parte dipartimenti universitari e aziende di consulenza, dall’altra i contatti ufficiali e gli enti sanitari pubblici caratterizzati da logiche di potere e rigidità ben lontane da valori e da obbiettivi a se stanti. In particolare, se a livello di direttive, o linee guida di sviluppo organizzativo, il pubblico sembrava aprirsi a programmi di cambiamento, poteva capitare di evidenziare anche l’emersione e l’entrata in gioco di interessi altri (per esempio si aveva il timore di inficiare le “storiche” relazioni tra professionisti privati (in primis i medici di base) e gli operatori pubblici). Il loro linguaggio del corpo, le espressioni di serenità piuttosto che quelle di perplessità, le scuse di un lavoro urgente sul paziente per uscire temporaneamente dalle riunioni, o solo il loro silenzio nel dare un’opinione: tutti elementi che facevano trapelare un reticolo culturale poco trasparente.
Legato a questo argomento ricordo che nelle prime fasi di indagine, assieme al responsabile di progetto, che era anche un membro della mia azienda, ho suggerito di condurre interviste individuali con gli stakeholder sanitari, così da comprendere meglio le logiche comportamentali che esistevano indipendentemente dal progetto in questione. Ho fatto presente che sarebbe stato prezioso per me capire come gli attori coinvolti percepivano le principali sfide dell’organizzazione, le barriere per superarle, e i rapporti sia tra gli altri attori sia tra i cittadini che visitavano ogni giorno.
Come emerso in seguito, le interviste sono state molto più rivelatori di qualsiasi incontro formale con il lato sanitario (classica situazione dove chi sta al vertice di un sistema piramidale è poco interessato ad avere contatti con gli operativi). Sebbene con qualche iniziale perplessità, la maggior parte delle persone con cui mi sono interfacciata, e che ho osservato nelle prime interazioni esplorative, ha individuato nella cultura dell’intero dipartimento, e nel settore sanitario un ostacolo fondamentale, descrivendola come “loro (personale medico MMG – che ricordo è un profilo privato a supporto del pubblico) fanno quello che vogliono tanto non fanno parte del (servizio) pubblico, ma collaborano con noi come privati e ne abbiamo bisogno”, oppure “sono io che uso il mio tempo extra per scrivere di più così forse dall’altra (parte) quando si va dal paziente siamo tutti aggiornati, ma poi non credo neanche che loro leggano i dati e poi a noi spetta corrergli dietro..”, “c’è una logica dall’alto verso il basso” e “è demotivante per noi come operatori e inefficiente verso i pazienti”. Tutte le persone che ho coinvolto nell’indagine preliminare hanno visto il progetto come essenziale per sfidare il pensiero corrente e sviluppare soluzioni innovative, anche se queste avrebbero potuto causare dei disagi iniziali in fase di gestione del cambiamento.
Diciamo che appariva abbastanza chiaro per alcuni, in maniera più o meno formale e diretta, il dubbio sull’efficacia di questo metodo per portare insight nuovi a ciò che a livello sistemico era vissuto, o sottaciuto ed in parte accettato. Come spesso accade si ritiene che interventi drastici dall’alto o nuove “versioni” dell’alto portano in tempi minori evidenze e risultati migliori.
Indagine culturale tramite l’action research e l’etnografia organizzativa
Se alcune persone che intervistavo mi davano molta fiducia circa il successo del progetto e si dimostravano anche desiderose di introdurre (quindi sostenere) dei cambiamenti (organizzativi, culturali e tecnologici se fosse potuto servire), dall’altra parte c’erano altrettanti operatori sanitari che si dimostravano passivi e condividevano controvoglia idee che potevano mettere a rischio lo status quo difficilmente raggiunto o mantenuto in una vita di lavoro. Questa situazione più che stressarmi mi dava ancora più energia, perché c’era chiaramente del vissuto, del dato informativo da portare a galla per avere un puzzle convincente per tutti. Da quel momento sono passata al secondo step d’indagine: dopo le interviste esplorative ho condotto una decina di osservazioni etnografiche sul campo, ossia l’attività che prevedeva l’affiancamento “mascherato” quotidiano a fianco degli operatori sanitari prescelti nella loro intera giornata tipo (nel concreto ciò significava mascherarmi ad ogni uscita come un’apprendista infermiera o altra figura richiesta al momento (questo per non alterare in alcun modo il percepito del paziente e di conseguenza l’operato della figura sanitaria). A livello pratico ciò si traduceva nella mia nuova giornata tipo: accesso al distretto territoriale infermieristico della provincia alle ore 7.50 del mattino, quindi mi direzionavo come una normale dipendente nella sala “infermieri territoriali” dove tutti gli operatori entravano a poco a poco. Da lì mi affiancavo ad un operatore e si iniziavano gli spostamenti presso i domicili dei pazienti per poi riprendere nel pomeriggio le attività di back office, senza dimenticare il rituale delle pause pranzo tutti assieme. Come capita ad ogni etnografo dopo “un po’” sono passata dall’essere l’estranea per diventare poi un novizio accetto nel gruppo; insomma, ero diventata una di loro (ricordo che, per ovvi motivi professionali non agivo da sanitaria ma mi limitavo “ad apprendere il mestiere, con tutto ciò che questo implicava” da un punto di vista strettamente metodologico). Inoltre alcuni pazienti mi scambiavano per un’infermiera o assistente sociale a seconda della loro storia, mentre invece stavo li ad immergermi nel lavoro degli operatori (e tutto il conseguente livello di vita relazionale, la strumentazione, lo stress degli spostamenti sul territorio e le dinamiche dei gruppi in ufficio).
La conseguenza sostanziale e a posteriori direi di fondamentale era che, prima ancora di raccogliere dati da comprendere e unire, in corso d’opera, come un puzzle, il mio ruolo di etnografa culturale assumeva una duplice funzione: da un lato stavo creando una relazione di fiducia non solo con l’utente finale (che mi accoglieva costantemente, mi forniva accesso al campo e si prestava a sessioni di co-design o approfondimenti che ritenevo necessari), ma anche con gli altri stakeholder di progetto, perché vedevano nella mia figura quell’elemento che, in quanto generatore di legami di fiducia solidi con i diversi gruppi coinvolti, rappresentavo una sorta di jolly (o per meglio dire di attante liminale) in grado di fare da ponte in questo processo di raccolta dati, comprensione e condivisione dati bilaterale tra ogni gruppo.
Co-creazione e workshop
Ad un certo punto, dopo settimane di raccolta dati, io e i miei colleghi abbiamo programmato un workshop di co-design di mezza giornata con l’intero gruppo di utenti finali, invitando anche il responsabile del dipartimento infermieristico. Ho fornito un breve estratto di alcune intuizioni della ricerca da condividere con loro e ho esortato a sottolineare l’importanza del progetto e la partecipazione a questa fase.
La sessione di co-creazione è stata estremamente fluida, e ha visto una partecipazione di gruppo per la sua intera durata. Ricordo che tra un discorso e l’altro, una delle infermiere ha detto “Perché non proviamo a sentire anche “quella figura”, magari trova il tempo di passare, questo ci aiuterebbe anche su altre attività che seguono la stessa logica di questa, sarebbe molto utile!”.
Durante i workshop ho raggruppato strategicamente alcuni stakeholder così da generare un dibattito produttivo e sfidante, volto a generare nuovi spunti per il futuro sistema organizzativo e lavorativo. Il responsabile degli infermieri ha collaborato con i sottoposti, tra i quali c’erano sia operatori con una certa seniority sia operatori che si erano aggiunti al gruppo più di recente. Ho osservato come, a fronte di un iniziale timore ad esporre le proprie idee, o a condividere fino in fondo quanto accadeva nella realtà, dopo pochi iniziali interventi è emersa una logica di gruppo dove le persone pensavano al bene del team prima del singolo vantaggio personale. Quindi se all’inizio, qualcuno sembrava a disagio, perché non poteva controllare l’ambiente e i rituali sembravano messi in discussione, nel corso del workshop ho potuto notare come il gruppo si sia compattato, e tutti siano diventati sempre più partecipi e coinvolti. Fondamentali sono stati gli interventi degli operatori storici che più di altri credevano nel lavoro in corso. , Questo ha fatto sicuramente la differenza nel creare un senso di appartenenza e dovere verso la sostenibilità della professione sanitaria.
Riflessioni finali
Posso dire che questo è stato il primo progetto nel quale ho avuto modo di essere coinvolta dall’inizio alla fine del processo di change management (circa un anno e mezzo di lavoro, mentre la parte d’indagine pure si è organizzata lungo l’arco di 5 mesi di progetto). Ho imparato vivendo sul campo che il rapporto di lavoro che un consulente o un’agenzia intrattiene con i clienti sui progetti è di per sé un campo etnografico, pieno di micro interazioni sociali. Nel mio caso c’era il committente, le cerchie professionali sanitarie (i diversi operatori che affiancavo sul campo), i colleghi consulenti, i dipartimenti universitari, senza dimenticare i pazienti finali. Ho capito che per raggiungere i risultati di progetto e per avere realmente un impatto a lungo termine (ricordiamo il contesto sanitario) la figura dell’etnografo ha bisogno di scoprire, comprendere, navigare, e anche facilitare le dinamiche culturali dell’intera cerchia di attori coinvolti, proprio per la natura relazionale e di fiducia che si crea. Tutto ciò senza dimenticare poi che si ha bisogno del lavoro di squadra, di oliare i meccanismi anche sul fronte del lavoro consulenziale e cross-functional team (in questo caso anche cross-organizations).
Dopo anni di esperienze simili, posso concludere portando a galla due, tra i tanti, spunti metodologici che ho usato. Possiamo dire che potrebbero essere anche intesi come linea guida per un processo d’indagine etnografica
Ecosistema a 360 gradi
Un approccio sistemico comprende i diversi fattori che danno forma a una cultura. Troppo spesso la cultura organizzativa viene definita in base a un momento o a un’interazione specifica, ma così facendo si dedurrebbe una visione parziale e limitata. Per esempio, nella mia esperienza ho descritto ciò che ho compreso durante le osservazioni sul campo e il modo in cui gli individui e i team si sono comportati in quel momento. Ma ho fatto molto di più: ho studiato la storia, i valori, le strutture di leadership, le politiche pubbliche (servizio sanitario provinciale) e private (medici di base), la progettazione degli spazi fisici e altro ancora in modo da poter comprendere il contesto culturale più completo di quelle micro-interazioni. Tecnicamente si parla di allargare lo sguardo, perché è questo che permette di cambiare prospettiva e andare oltre l’ovvio e la superficie. Tutti questi fattori modellano il modo in cui le persone si comportano e pensano; come i rituali di resistenza e potere possono modellare gli aspetti delle dinamiche di gruppo. Questo è, ovviamente, il punto centrale di ogni buona etnografia. Un approccio a 360 gradi vi permette di capire più a fondo come si forma la cultura che state indagando (specie nei casi in cui si parta anche senza un focus specifico, come accade nell’approccio della grounded theory ad esempio) e come interagisce con voi in un progetto. Vi aiuterà a individuare le potenziali sfide che potrebbero presentarsi nel corso del progetto e a capire come gestirle e facilitarle.
Ingranaggi liminali
Se un approccio sistemico vi aiuta a comprendere la cultura del vostro cliente, la liminalità è un quadro di riferimento per lavorare con o interrompere queste dinamiche, come ho fatto con il primo workshop di co-creazione, o nei rapporti tra gruppi delle diverse organizzazioni partecipanti al progetto. Le intuizioni o le raccomandazioni strategiche che il vostro progetto fornisce dovrebbero sfidare il cliente in modo costruttivo, consentendogli di vedere nuove opportunità senza però metterlo in allarme e in uno stato di freeze.
Sappiamo che ogni sfida è accompagnata da un cambiamento; il cambiamento spesso induce disagio e il disagio scatena resistenza. Quando si crea volontariamente e con una certa maturità, uno spazio liminare, allontanate fisicamente e mentalmente il cliente dalla sua automatica routine, costruendo intenzionalmente uno spazio più aperto alle possibilità. Questo è fondamentale e strettamente connesso alla costruzione del rapporto di fiducia, tanto quanto lo è nella creazione di spazio aperto e legittimo nell’operato tra team cross-funzionali. Spesso nelle ricerche che conduco (siano esse interviste o osservazioni sul campo) parlo di campo vibrazionale e spazio generativo (come sinonimi) perché questo aiuta a passare da uno stato di automatismo e staticità ad uno sommerso o liminale quindi parzialmente sovrapponibile al nostro.
Tramite il canale della liminalità, sta poi all’etnografo sfruttare l’artefatto, il linguaggio, il momento giusto per portare gli attori da una prospettiva ad un’altra con naturalezza e senza forzature. Prendiamo l’esempio di un workshop di fine progetto, quando condividete le vostre brillanti intuizioni e volete che il vostro cliente inizi a sviluppare soluzioni o strategie basate su di esse. Dalla mia esperienza se inquadrate anche quel workshop come uno spazio liminale, potete usarlo come veicolo per il cambiamento, con performance e rituali che sfidino e coinvolgano in modo costruttivo le percezioni dei vostri clienti per aiutarli nella transizione. Quando sono con i colleghi parlo anche della pausa caffè come spazio liminale per fargli capire il concetto e la potenza di quel campo.
Riferimenti
Ho condotto questo ragionamento nell’ambito di un lavoro svolto nell’anno 2010. L’argomento è stato l’investigazione del ruolo liminale dell’etnografo organizzativo (il consulente) all’interno di un progetto di ricerca cross-funzionale e cross-aziendale nel contesto della sanità domiciliare trentina (scopo del progetto era l’adozione e sperimentazione di nuovi modelli digitali e organizzativi nel tessuto lavorativo della Provincia di Trento). Il risultato del lavoro è stato presentato lo stesso anno al Workshop “Coordination, Collaboration and Ad-hoc Processes” presso gli HP Labs di Palo Alto.
Related Articles
-
info@cultureflow.it
-
Site made by MDESIGN